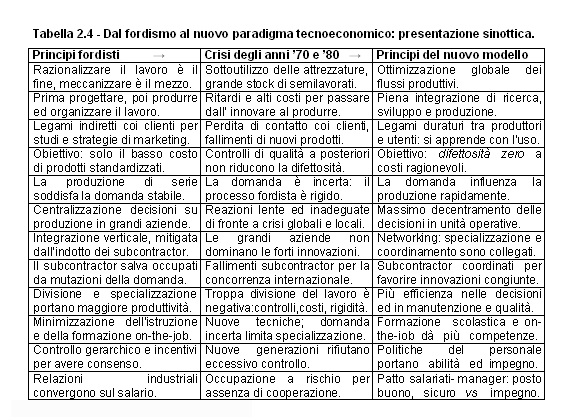
Fonte: nostra elaborazione Boyer (1989)
CAPITOLO II
L'ICT e l'Occupazione
2.4 La flessibilità salariale ed organizzativa e la professionalità
Per superare la disoccupazione strutturale è convinzione comune che sia indispensabile la flessibilità nel mercato del lavoro,
cui si possono attribuire vari significati. La tradizione classica parla della rilevanza della flessibilità dei salari e della
mobilità della manodopera. Invece, gli storici hanno dato rilievo alle migrazioni internazionali ed all'urbanizzazione.
Negli ultimi anni, un effettivo aumento del grado di flessibilità dei rapporti di lavoro ha caratterizzato le politiche
dell'occupazione in Italia ed in Europa ed ha portato conseguenze importanti, come la concorrenza dei Paesi a basso salario
e l'incremento del livello di partecipazione delle donne in tutti i Paesi industrializzati. Questo è dovuto in parte ai datori
di lavoro (che hanno cercato continuamente manodopera a minor costo) ed in parte alle recenti ristrutturazioni organizzative
dei processi produttivi (che sono connesse proprio alla massiccia diffusione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione).
Si è già visto che una delle caratteristiche tipiche del paradigma ICT è la flessibilità progettuale, produttiva, commerciale
e distributiva dei servizi (che permette di ridurre la mobilità geografica).
Esistono poi altri due importanti tipi di flessibilità: uno legato alle modalità di organizzazione del lavoro e l'altro
all'apprendimento di nuove competenze da parte dei lavoratori. Entrambi sono necessari ad affrontare i cambiamenti del
product mix e delle tecniche produttive.
Conseguire la flessibilità organizzativa e delle competenze è estremamente più difficile che ottenere quella classica
nell'offerta di lavoro: esse, comunque, dipenderanno solo dalle capacità di ciascun Paese di promuovere veloci cambiamenti
tecnici ed istituzionali e di innalzare rapidamente le produttività, destinando però i relativi guadagni all'ampliamento
dell'occupazione.
La tradizione classica e neoclassica dell'occupazione e del progresso tecnico si basa su vari meccanismi di compensazione
per ripristinare l'equilibrio sul mercato del lavoro, bilanciando domanda ed offerta di manodopera.
Il ruolo della flessibilità dei salari e dell'interesse è essenziale, anche se il mercato del lavoro non può
essere assimilato agli altri. Comunque, il tema della distribuzione delle quote di profitto è stato sempre fonte di
acuti problemi sociali.
Secondo alcuni economisti (Layard e Philpoytt, 1991), per contrastare la disoccupazione di lungo periodo, più della
flessibilità sono necessari una forte attenzione all'addestramento, l'obbligo di accettare lavoro o formazione ed
anche spinte e stimoli finanziari, sia per il datore di lavoro sia per il disoccupato.
Secondo altri, invece, sia in Nord America sia in Europa, esiste la necessità di ridurre i salari relativi
(ed i benefici sociali) ai lavoratori meno qualificati ed ai giovani, poiché si ritiene che sia l'assenza di
flessibilità salariale all'ingiù a non ampliare il potenziale di creazione di lavoro a bassa professionalità/basso salario.
Così non è stato nella realtà dove, a causa di una penetrazione più consistente dei prodotti importati, sono proprio i
settori a basso salario ad aver maggiormente sofferto del calo occupazionale.
Paradossalmente, quindi, perseguire la flessibilità salariale sembrerebbe volere attuare una politica fondamentalmente
protezionista di autarchia. Questa creerebbe un'occupazione di certo superiore a quella persa col calo delle esportazioni
verso il resto del mondo, ma produrrebbe un ovvio calo del benessere. Inoltre, la perdita degli stimoli competitivi dinamici,
derivanti dalle importazioni, danneggerebbe la crescita e la competitività. Invece, in un mondo aperto, la diminuzione dei
salari porterebbe all'"importazione del sottosviluppo¹" (Freeman e Soete, 1994, pp. 120 - 121).
In conclusione, è evidente che gli argomenti a favore di un ribasso dei salari risultano essere sostanzialmente deboli.
Per evitare la disoccupazione, sono indispensabili mutamenti istituzionali che assicurino nel lungo periodo le
aspettative positive e la stabilità necessaria nelle relazioni industriali. In questo senso, alla soluzione del
ribasso dei salari è senz'altro preferibile un passaggio veloce ad attività altamente qualificate, a forte valore aggiunto,
anche se le politiche tipiche per recuperare parte dei profitti durante i cicli negativi si fondano prevalentemente
sull'indebolimento (se non addirittura sull'assoluto divieto) dei sindacati.
Tuttavia, questo rischia di diminuire la domanda
aggregata di beni di consumo, di aggravare la crisi e la disoccupazione keynesiana.
Oltrepassando la teoria tradizionale della flessibilità salariale, risulta di estrema rilevanza quella organizzativa e dei
contratti di lavoro, come anche la qualificazione dei lavoratori² .
In un'economia di mercato, queste possono essere fornite
dal subcontracting³ , che consente alle aziende di adeguarsi alle modifiche nella composizione e nei tempi dei nuovi ordini da evadere.
Le PMI permettono l'ottenimento della flessibilità: con la loro nascita ed il loro sviluppo, esse sono state riconosciute
dappertutto come indispensabili per rinnovare lo sviluppo occupazionale e la flessibilità stessa del sistema.
L'uso dell'ICT ha accentuato la domanda di forme di impiego che non definiscano orari di lavoro standardizzati e che siano
accompagnate da minori vincoli contrattuali.
Alcune indagini recentemente svolte dall'Isfol (Colella, 2001)4
consentono di analizzare l'impatto effettivo sul mercato del lavoro italiano del ricorso a lavoro part-time ed a quello a termine.
Grazie al recepimento della Direttiva U.E. n. 81/1997 sul part-time5 , attualmente i contratti con questa modalità contrattuale
costituiscono l'8,4% dell'occupazione complessiva.
Nell'anno 2000, quasi un quarto dei nuovi occupati è stato assunto con questa
modalità contrattuale. Precedentemente, il 47% di essi era inattivo od in cerca di occupazione, il 28% aveva un contratto a tempo
indeterminato, il 9% un contratto a termine ed il 16% un lavoro autonomo.
I dati Isfol mostrano un incremento tendenziale della
probabilità di trovare un'occupazione con un lavoro part-time.
Purtroppo, però, diminuisce la probabilità di passare da un
contratto a tempo parziale ad uno a tempo pieno.
Studiando gli esiti occupazionali a dodici mesi degli occupati a tempo
parziale dell'aprile 1999, si rileva che su 1.600.000 lavoratori, il 16% non ha più un'occupazione, il 58% rimane a part-time,
mentre il 25% ottiene un contratto full-time. La media delle ore lavorate è di 30 ore settimanali, con massimi di 36 ore per
il 16% degli occupati a tempo parziale.
Riguardo al lavoro a termine, per l'Isfol tra il 2000 ed il 2001 è aumentato solo del 2,8%, perché il lavoro dipendente di
questo tipo comprende in sé molti tipi di rapporti: il contratto a tempo determinato
propriamente detto6 , l'apprendistato 7,
l'interinale8 , il tirocinio9 ,
il contratto di formazione lavoro (CFL)10 ,
il job sharing11 ed anche il piano di inserimento
professionale (sebbene quest'ultimo non sia un rapporto di lavoro in senso stretto).
La crescita del ricorso all'apprendistato ed ai CFL rivela una consistente battuta di arresto: i primi sono stati oggetto di una riforma "non metabolizzata" dalle imprese, invece, i secondi sono stati "troppo tenuti sotto osservazione" dagli organi di controllo comunitari. L'interinale è decollato, ma la sua incidenza sul lavoro a termine è ancora limitata con solo 40-50.000 unità l'anno. Gli stage possiedono grandi potenzialità, anche se al momento hanno scarsa consistenza numerica, mentre i piani di inserimento professionale stanno esaurendo la loro funzione. In ogni caso, da questi accordi scaturiscono alti livelli di soddisfazione del lavoro.
Il lavoro a termine ha visto diminuire presenze maschili (- 29.000 unità), mentre la sua flessibilità ha portato un incremento
delle presenze femminili di 69.000 unità nell'ultimo anno, tanto da arrivare al 51% del totale degli occupati a termine
(contro il 46% di soltanto cinque anni fa).
Si riscontrano schemi più flessibili nel privato che nel pubblico, sebbene le cose stiano cambiando anche in questo ultimo settore.
Con più precisione ci riferiamo alla terza Legge Bassanini, la n. 191 del 1998, con la quale è stata sancita, grazie al ricorso
solo in via sperimentale al telelavoro12 , la nuova era della flessibilità nel pubblico impiego.
Tuttavia, non bisogna trascurare i rischi del trend verso un lavoro part-time flessibile.
Questi possono riassumersi in un ritardo della sicurezza sociale nell'adeguarsi ai cambiamenti ed in un tentativo
da parte di alcune aziende di sfuggire alle proprie responsabilità nei confronti dei dipendenti con questo tipo di contratto.
Inoltre, esistono rischi rilevanti per la competitività di un'impresa che nascono dalla sottovalutazione del capitale umano:
a tutti è manifesta l'esistenza di un forte legame tra stabilità dell'impiego e formazione professionale.
Caratteristica dell'aumento della disoccupazione strutturale negli ultimi anni è la crescente "incompatibilità"
tra i posti di lavoro perduti e le attuali possibilità di impiego, in termini sia di formazione, sia di esperienza.
Per quanto concerne più direttamente l'argomento qui trattato, il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro legato
all'ICT è anche dovuto alla differenza tra le professionalità ricercate dalle imprese e quelle offerte dalla manodopera
in cerca di occupazione.
Conseguenze dirette del progresso tecnico sono cambiamenti strutturali e mutamenti della domanda di professionalità e qualificazione.
La tabella 2.4 rileva che l'incompatibilità nelle specializzazioni della forza lavoro proviene dai mutamenti nella composizione
settoriale del prodotto e della stessa forza lavoro e pure dai mutamenti all'interno di ciascuna impresa, avvenuti per lo meno
nel corso degli ultimi 50 anni.
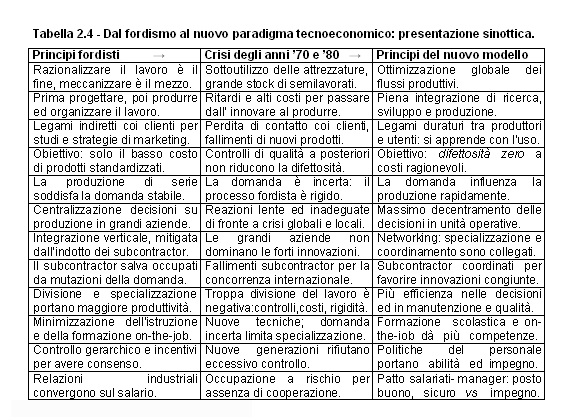
|
Top| Sommario| << Precedente | Successiva >>
" TARGET="_blank">>> Home Page << |